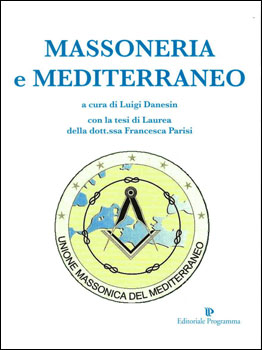di Ingrid H. Shafer
Le leggende del Graal rappresentano una fusione di elementi Cristiani e pre-Cristiani. Motivi comuni delle varie versioni della storia date da Chrétien de Troyes (ca. 1150-1190), Wolfram von Eschenbach (c. 1170-1220), ed altri, comprendono un castello magico, abitato dal castrato Re Pescatore, una vergine che porta il Graal, e un eroe maschile che ricerca il Graal. Il testo irlandese precristiano ''Adventures of Art, Son of Conn'' (Avventure di Art, figlio di Conn) già contiene la maggior parte dei temi della ricerca del Graal. Il Graal stesso è variamente identificato come una coppa luminosa, una boccia, un gioiello e (da Wolfram) una pietra, in grado di donare un'infinità di cibo e bevande. E' una fonte di giovinezza e salute, sorgente di saggezza e verità. Durante una visita con il dio Manannan, il re Cormac (figlio di Art) e la sua famiglia si trovano ad un tavolo coperto da una tovaglia che - all'improvviso - inizia a produrre cibi e bevande a volontà. Nella sua forma cristianizzata, il Graal è stato identificato con la coppa usata da Cristo durante l'Ultima Cena, il contenitore in cui il suo Sangue è stato raccolto da Giuseppe d'Arimatea, e la coppa eucaristica. Il re Pescatore è generalmente associato ad una lancia sanguinante (che lo avrebbe ferito), a sua volta collegata con la lancia del dio celtico Lug e con la lama che ha trafitto il fianco di Gesù in croce.
Riflettendo su questi motivi, Roger Sherman Loomis ha concluso che la tradizione del Graal è celtica in origine, poiché "viola le più elementari regole dell'etica e dei rituali cristiani", e per questo "non sarebbe sorta in ambienti cristiani". Per sottolineare il concetto, egli chiede: ''Come è possibile che una sacra reliquia, o anche solo una comune patena o un ciborio, possa essere affidata ad una amabile fanciulla, e non ad un prete o un sacrestano?"
Rispondendo alla sua retorica domanda, egli conclude: "Non c'è da meravigliarsi se la Chiesa non ha mai riconosciuto i romanzi del Graal come autentici, anzi, ha mostrato sempre sospetto per il loro background non molto ortodosso".
Ovviamente, la storia del Graal, particolarmente nelle sue origini celtiche e secondo la versione di Wolfram, si sposa bene con una teologia che insiste sull'assoluta mascolinità di Dio, l'inferiorità della donna e su una morale che esalta l'ascetismo sessuale. La moderna tradizione cattolica, tuttavia, esalta il ruolo di Maria come "Madre di Dio" (con un termine greco theotokos o "Portatrice di Dio"), e le sue caratteristiche materne, che in passato erano viste nella antica Magna Mater. Ed oggi, trent'anni dopo il II Concilio Vaticano, le donne possono servire come ministri eucaristici.
I modi di interpretare e descrivere il Graal sono molti e controversi; ciò può essere giustificato dal fatto che il tema del Graal cominciò a diffondersi durante il Medioevo, periodo di intenso fermento in fatto religioso e agitazione intellettuale. Il Graal è un potente simbolo che rappresenta insieme la fecondità femminile, la saggezza, la divinità. Non soltanto la portatrice del Graal è quasi sempre una giovane fanciulla, ma il Graal stesso contiene la luminosa immagine di un bambino su di sé o sopra l'ostia che vi è contenuta. Ci vuole un po' di immaginazione per vedere in questa immagine l'archetica connessione tra il Graal-grambo materno, e la storia cristiana dell'Incarnazione-Annunciazione, simboleggiata dalla coppa eucaristica. In questo contesto è interessante notare che Henry e Renée Kahane sostengono che Graal derivi dalla parola greca krater, concetto chiave per gli ermetisti.
E' sicuramente più di una semplice coincidenza il fatto che le leggende del Graal siano nate proprio in un periodo in cui i dibattiti più accesi dell'epoca concernevano il mistero dell'Eucarestia, una controversia che culminò nella promulgazione del dogma della transustanziazione del IV Concilio Laterano del 1215. Nella liturgia, l'Eucarestia diventa "Comunione", il sacro pane sacramentale, cibo spirituale nella forma di pane e vino. Questo sottolineò l'importanza dell'Incarnazione, e della presenza di Dio-nel-mondo, in contrasto con la posizione dei Catari, i quali sostenevano che il mondo e qualsiasi cosa in esso, compreso il matrimonio e la procreazione, erano il "male", e il corpo di Cristo soltanto un'illusione. Per loro. come nelle leggende l'importante era vedere il Graal, così anche solo assistere all'elevazione dell'Ostia consacrata aveva lo stesso effetto di grazia della partecipazione alla Comunione. Dopo una durissima persecuzione, i Catari (anche chiamati Albigesi) furono sterminati. Ironicamente, la loro dottrina dualista non si estinse completamente, ma influenzò la frangia Neo-Platonica dei cattolici con la sua visione negativa della vita e del mondo.
Tra le numerose versioni medievali della Ricerca del Graal, Mircea Eliade considerò il Parzival di Wolfram von Eschenbach come ''la più completa storia e coerente mitologia del Graal''. Eliade fu colpita in particolare dal fatto che deliberatamente Wolfram incluse numerosi motivi orientali, e fece ciò con molto rispetto. Wolfram sostenne che la fonte originaria del suo racconto era una saga Ebraico-Musulmana; il padre di Parzival visse per un po' di tempo in Africa, dove si sposò con una musulmana ed ebbe un figlio; questi viaggiò a lungo in Asia ed Africa; il fratello di Parzival sarebbe presto diventato il celebre prete Gianni, monarca Indiano.
In breve, Eliade nota che
[...] è evidente che il simbolismo del Graal dell'opera di Wolfram e dei suoi successori e lo scenario da loro dipinto, rappresenta una sintesi spirituale che va oltre i contributi delle diverse tradizioni. Dietro il suo interesse nei confronti dell'Oriente, si può intravvedere la profonda disillusione causata dal fallimento delle Crociate, l'aspirazione ad una tolleranza religiosa che avrebbe incoraggiato un avvicinamento al mondo dell'Islam, una profonda nostalgia di una "cavalleria spirituale" [...]
Nella tradizione celtica originaria, tuttavia, e nel racconto di Wolfram, l'amore umano e l'aspirazione alla sessualità sono trattati come valori positivi. In contrasto con il Galahad di Chrétien (che raggiunge il Graal attraverso una vita di ascesi e di rinuncia ai piaceri della carne, mantenendosi un cavaliere vergine - e proprio per questo considerato perfetto), Parzival raggiunge il Graal spirituale pur con la sua amata Condwiramurs. Wolfram considera l'amore nuziale come un misterioso ed potentissimo sacramento.
Inoltre c'è un preciso passo in cui si evidenzia che proprio tramite il suo amore coniugale Parzival diventa degno del Graal. Il ricordo di sua moglie Condwiramurs non solo lo sostiene nel suo vagabondare, ma la sua elezione a Re del Graal è immediatamente seguita da una notte d'amore con la sua Condwiramurs in una tenda della foresta. Wolfram scrive: ''Così, io credo, si prese piacere fino a mezzo il mattino. Da ogni parte l'esercito si fece da presso a guardare [...] Ora non era più tempo di dormire. Il re e la regina si alzarono. Un prete cantò la messa" (Wolfram 802). Dal passo pare ovvio che Wolfram consideri un atto d'amore tra il re e la regina come una valida ragione per ritardare la celebrazione. Qui, come in altre opere epiche, Wolfram rifiuta il fatto che la Chiesa sia la sola mediatrice tra Dio e l'umanità. Proprio questo anticlericalismo può spiegare l'insinuazione che Wolfram fosse in realtà un Cataro.
Così Wolfgang Spiewok, il traduttore tedesco, scrive nel suo commento: ''Wolfram trasforma l'amore romantico cortese (Minne) nel genuino amore coniugale: fondamento del matrimonio, che in questo trova compimento'' e, per Wolfram ''Dio non si incontra (come sostenuto da alcuni chierici) attraverso l'ascetismo e il rifiuto del mondo, ma attraverso le relazioni sociali vissute al servizio di Dio." Secondo Spiewok, è proprio questa visione non dualistica del mondo materiale l'elemento che assicurò a Wolfram una immensa popolarità delle sue opere durante i successivi secoli che precedettero la Riforma. Se Spiewok ha ragione, allora la storia raccontata da Wolfram rappresenta un antidoto popolare al prevalente dualismo del tardo Medioevo.
Fonte primaria:
Wolfram von Eschenbach. Parzival.
Fonti secondarie:
Eliade, Mircea. A History of Religious Ideas Volume 3: From Muhammad to the Age of Reforms. Trans. Alf Hiltebeitel and Diane Apostolos-Cappadona. Chicago: The University of Chicago Press, 1985.
Jungmann, Joseph A. The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development (Missarum Sollemnia). 2. Vols. Trans. Francis R. Brunner. Westminster, ML: Christian Classics, 1986.
Kahane, Henry and Renée. The Krater and the Grail: Hermetic Sources of the Parzival. Urbana: University of Illinois Press, 1965.
Loomis, Roger Sherman. Arthurian Tradition & Chrétien de Troyes. New York: Columbia University Press, 1961.
Markale, Jean. Women of the Celts. Trans. A. Mygind, C. Hauch and Peter Henry. London: Gordon Cremonesi, 1975.
Matarasso, Pauline M., trans. The Quest of the Holy Grail. New York: Penguin Books, 1984.
Matthews, John. The Grail: Quest for the Eternal. New York: Crossroad, 1981.
Neumann, Erich. Die Große Mutter: eine Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des Unbewußten. 1974. Olten: Walter-Verlag, 1985.
.
Copyright © 1996, Ingrid H. Shafer.
Questo file può essere copiato a condizione che il suo intero contenuto (compreso questa nota di copyright) rimanga intatto.